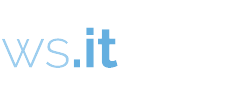Il mio amico Matteo è un esperto di montagna. È un filosofo colto e un trombettista talentuoso, e mi ha insegnato il passo nobile e cadenzato con cui affrontare ogni ascesa, e non solo. Mi diceva: “È ottimo allenarsi in palestra, correre nel parco e sulla pista ciclabile, fare esercizi cardio, ma alla fine, non c’è niente di meglio che essere in natura”.
Era l’anno del Covid e mi stavo preparando per scalare tre delle quattro vette italiane sopra i 4000 metri. A causa delle restrizioni, correvo di notte nel parcheggio dei garage, salivo e scendevo le scale del condominio di 9 piani, facendo attenzione a non fare rumore e a non scivolare sui gradini di marmo o sugli zerbini, camminavo ovunque ogni volta che potevo. Quando le restrizioni sono state revocate, ho iniziato ad andare “in natura”. Il mio “palestra all’aperto” è stato il Campo dei Fiori, sopra Varese. Partivo dal Chiostro di Voltorre e arrivavo alla Punta di Mezzo, a 1215 metri sul livello del mare, con un dislivello di 1000 metri dal lago.
Ben prima dell’alba, attraversavo Comerio fino alla frazione Mattello, da dove parte il sentiero 312, un percorso diretto che entra nel bosco, lasciando a destra la deviazione per la grotta Remeron, e si inerpica fino al punto più alto e più vicino a Milano di tutta la Lombardia. Un giorno ho trovato la nebbia umida e gelata, un altro un sole caldo e accecante, un altro ancora una pioggia leggera e viscida. Mi sono perso cambiando percorso in discesa e una volta ho deciso di andare oltre fino a Castello Cabiaglio, con ritorno da Gavirate. Ho incontrato cinghiali che si stavano “lavorando” i giardini delle ville alle prime luci dell’alba e cervi e caprioli sorpresi dalla mia presenza.
Una volta ho aiutato un signore pallido, rimasto solo con la sua bicicletta elettrica scarica. Il profumo delle foglie umide e della resina di un abete a cui mi sono aggrappato ha riempito le mie narici. Ho ascoltato il mio respiro, il battito del cuore nelle tempie, il sasso che rotola e si ferma, il fringuello che vola via, la poiana che strida in volo, il sussurro delle foglie dei faggi. L’acqua nella mia borraccia ha ammorbidito la mia bocca, arsa dalla fatica dell’ascesa. David, Filippo e Alessio sono venuti a farmi compagnia, qualche volta solo per la seconda scalata del giorno. Ho sbagliato scarponi (quelli per il ghiaccio e i ramponi si rovinano più velocemente sulla roccia). Ho dimenticato lo zaino e l’orologio contapassi. Ho rotto un bastone che si è incastrato sotto un ramo mentre correvo in discesa.
Tutto questo, e molto altro ancora, è “essere in natura”. Affrontare la variabilità del tempo, apprezzare le meraviglie e gestire gli imprevisti, essere esposti con tutti i sensi, e in ogni senso, all’imprevisto. Incontrare e entrare in relazione, anche se solo per un attimo, con la fauna, la flora e le diverse umanità. Soprattutto, rivelare e riscoprire un essere speciale da cui spesso scappiamo: noi stessi.
In un mondo in cui il virtuale domina il reale, le relazioni diventano piatte e ipertrofiche nella rete globale e la solitudine emerge come condizione esistenziale per molti, la metafora di essere in montagna può incoraggiarci a uscire dalle nostre gabbie fisiche e mentali, ad alzarci dai divani della mente, per vivere pienamente ogni esperienza. “L’esperienza non è ciò che accade a un uomo; è ciò che un uomo fa con ciò che gli accade”, Aldous Huxley.